
La lettura di Cristina Campo rappresenta per me un’esperienza singolare e, per così dire, ambivalente. Da un lato avverto il fascino di quest’esistenza nascosta, di questa sensibilità eccezionalmente acuta, di questa tensione alla purezza e alla bellezza assolute, di questa straordinaria ricchezza di letture, di questa capacità di pensare contro il proprio tempo. Dall’altro mi sgomenta questo stesso fare della bellezza il centro assoluto della vita, e della religione. È il modo di vivere la religione della Campo, è il suo modo di vivere e pensare il cattolicesimo, che mi dà travaglio. Mi sembra di essere rigettato in quel modo di sperimentare la fede che ho conosciuto negli anni 1950: forte identità, opposizione al nemico (rappresentato, più che dai comunisti, dai protestanti), ossessione della purezza (anzitutto in ambito sessuale, se non soltanto in questo), lotta contro il demonio, incensi e funzioni in latino. Sono la liturgia e il rito le cose belle per eccellenza, secondo Cristina Campo, che vive il passaggio dal latino al volgare nella messa come una tragedia spirituale tremenda, poiché … il paesaggio, il linguaggio, il mito e il rito, che sono i quattro elementi della felicità, sono oggi diventati i quattro bersagli dell’odio concentrato dell’occidente (p. 215 di Sotto falso nome, Adelphi, Milano 1998). In questo libro, che raccoglie testi vari composti in occasioni diversissime, pubblicati sotto pseudonimi diversi, mi sembrano particolarmente interessanti due elementi: la critica, se così si può definirla, a Simone Weil, che peraltro è un suo nume tutelare, perché non si sarebbe sufficientemente slegata dall’illuminismo delle sue origini (Alain) e non avrebbe letto abbastanza, anzi quasi nulla, dei grandi maestri spirituali della Chiesa, non avendone peraltro uno vivente adeguato a lei; e perché sarebbe stata, in fondo in fondo, troppo orgogliosa, troppo convinta di una propria autosufficienza spirituale. E però – in secondo luogo – nella Campo, la cui tensione alla perfezione dell’anima cosparge i suoi testi di perle di rara bellezza, mi sembra mancare la rivelazione dell’orrore della croce, l’elemento tragico dostoevskiano, senza il quale il cristianesimo rischia di apparire come una declinazione del religioso e del sacro, una delle possibili.
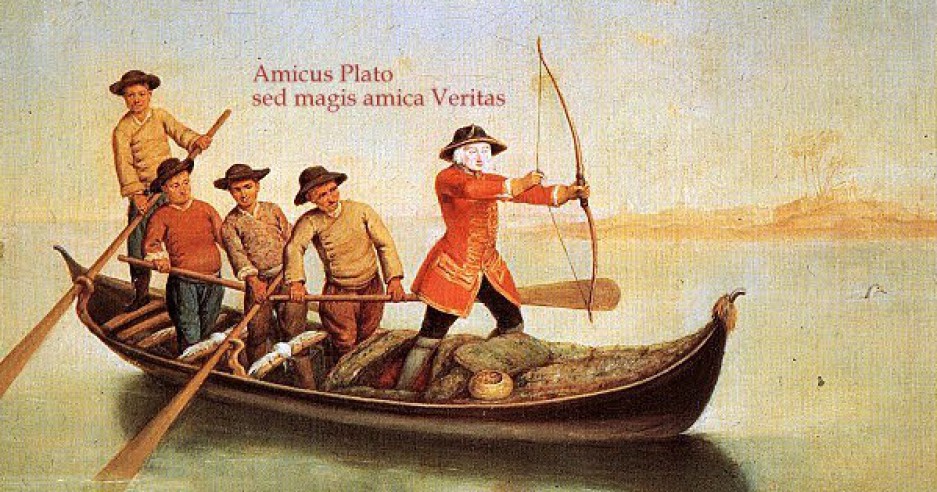
L’ha ribloggato su Brotture.