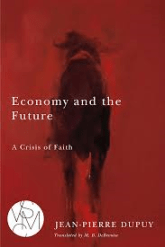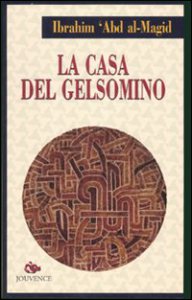Richiede un lettore paziente Gli scomparsi di Daniel Mendelsohn (The Lost. A Search for Six of Six Million, 2006, trad. it. di G. Costigliola, Neri Pozza 2007). Perché è un volume di più di 700 pagine, e perché la narrazione è fluviale e tortuosa, con rami secondari e deviazioni. Straordinaria indagine volta a recuperare gli ultimi anni del fratello del nonno materno, un prozio di Mendelsohn rimasto con la sua famiglia nella cittadina galiziana di Bolechow mentre i fratelli erano emigrati, Gli scomparsi attraverso una serie di incontri, alcuni dei quali davvero fortuiti, di dialoghi e di racconti di persone anziane che vivevano laggiù alla fine degli anni Trenta e durante la guerra, riesce a far riemergere, almeno in parte, un mondo totalmente cancellato e sepolto nell’oblio. Mendelsohn è interessato tuttavia a quelle persone, Shmiel Jaeger, la moglie Ester e le quattro figlie Lorka, Frydka, Ruchele e Bronia, e al loro mondo, non al mondo ebraico-orientale in genere. Il sottotitolo, che nella versione italiana non compare, è estremamente eloquente: è una ricerca su quei six, non l’ennesimo libro sui six million. Dalla sua famiglia a New York ha appreso pochissimo, sospetta che vi sia qualcosa di oscuro nel rapporto tra il prozio e i fratelli emigrati, e infatti emergerà infine un motivo antico di conflitto, che tra l’altro ha a che fare con l’osservanza religiosa. Nella sua complessità, avendo sempre sullo sfondo, e talvolta in primo piano, l’orrore dello sterminio nazista, questo è un libro sulla parentela e in particolare sul rapporto tra fratelli. Il frenetico girare per il mondo alla ricerca dei pochi che possono ricordare eventi e persone di sessant’anni prima è contrappuntato da un confronto con le pagine bibliche del Genesi, in un singolare e fruttuoso, e spesso tormentato dialogo.
Richiede un lettore paziente Gli scomparsi di Daniel Mendelsohn (The Lost. A Search for Six of Six Million, 2006, trad. it. di G. Costigliola, Neri Pozza 2007). Perché è un volume di più di 700 pagine, e perché la narrazione è fluviale e tortuosa, con rami secondari e deviazioni. Straordinaria indagine volta a recuperare gli ultimi anni del fratello del nonno materno, un prozio di Mendelsohn rimasto con la sua famiglia nella cittadina galiziana di Bolechow mentre i fratelli erano emigrati, Gli scomparsi attraverso una serie di incontri, alcuni dei quali davvero fortuiti, di dialoghi e di racconti di persone anziane che vivevano laggiù alla fine degli anni Trenta e durante la guerra, riesce a far riemergere, almeno in parte, un mondo totalmente cancellato e sepolto nell’oblio. Mendelsohn è interessato tuttavia a quelle persone, Shmiel Jaeger, la moglie Ester e le quattro figlie Lorka, Frydka, Ruchele e Bronia, e al loro mondo, non al mondo ebraico-orientale in genere. Il sottotitolo, che nella versione italiana non compare, è estremamente eloquente: è una ricerca su quei six, non l’ennesimo libro sui six million. Dalla sua famiglia a New York ha appreso pochissimo, sospetta che vi sia qualcosa di oscuro nel rapporto tra il prozio e i fratelli emigrati, e infatti emergerà infine un motivo antico di conflitto, che tra l’altro ha a che fare con l’osservanza religiosa. Nella sua complessità, avendo sempre sullo sfondo, e talvolta in primo piano, l’orrore dello sterminio nazista, questo è un libro sulla parentela e in particolare sul rapporto tra fratelli. Il frenetico girare per il mondo alla ricerca dei pochi che possono ricordare eventi e persone di sessant’anni prima è contrappuntato da un confronto con le pagine bibliche del Genesi, in un singolare e fruttuoso, e spesso tormentato dialogo.
Questo è anche un libro che pone inquietanti interrogativi sulle convivenze tra culture ed etnie, e sulle loro labili fondamenta anche secolari. Tre gruppi etnici, infatti, tre culture diverse avevano convissuto per secoli a Bolechow. Nel 1941 vi erano tremila ucraini, seimila polacchi e tremila ebrei. Nel 1945 dei tremila ebrei era rimasta in vita qualche decina. Oggi a Bolechow non vive nessun ebreo. Gli abitanti delle tre etnie si conoscevano, avevano rapporti di commercio e amicizia, ma all’improvviso tutto andò in frantumi. Un ennesimo spunto di riflessione per coloro che sono convinti che l’odio e la violenza nascano dalla non-conoscenza:
È storicamente accertato che molte delle efferatezze compiute contro gli ebrei dell’Europa orientale non vennero perpetrate dai tedeschi ma dalle popolazioni locali, polacchi, ucraini, lituani, lettoni; i vicini, persone con cui gli ebrei avevano convissuto intimamente per secoli, fino a quando quel delicato equilibrio si alterò ed essi si rivoltarono contro di loro. Alcuni trovano incredibile questo fenomeno—non da ultimo gli stessi ebrei. Più di un sopravvissuto con il quale ho parlato negli anni successivi a quel primo viaggio a Bolechow ha espresso sconcerto, rabbia o ira all’idea che i loro conterranei si fossero trasformati in assassini.
«Cannibali!» esclamò con stizza una donna a Sidney. «Per me sono cannibali. Avevamo vissuto porta a porta per anni—e poi ecco cosa è successo».
Un altro australiano conosciuto in seguito in modo del tutto casuale definiva «macellai» gli ucraini collaborazionisti, con il tono in cui si qualifica un informatore della polizia segreta o una spia. Un pomeriggio mi disse: «Strutinski era un noto macellaio, uccise molte persone. E ce n’era un altro, Matwiejecki, che si vantava di aver ammazzato con le proprie mani quattrocento ebrei. C’era anche una famiglia, i Manjuk—erano ucraini e parlavano perfettamente in yiddish, due fratelli che diedero la caccia agli ebrei durante l’Olocausto, uccidendone parecchi».
«Parlavano perfettamente in yiddish?» chiesi stupito. L’australiano annuì, e mi spiegò che parecchi cristiani di Bolechow, polacchi e ucraini, conoscevano molto bene l’yiddish: tanto stretti erano i loro rapporti con gli ebrei.
Con un mesto sorriso commentò: «Eravamo il primo esempio di società multietnica».
Avevo l’impressione che, al di là della dolorosa e amara disillusione, per non dire dello sconcerto, che molti manifestano di fronte al fatto che delle persone che hanno convissuto per lungo tempo in una certa intimità possano come niente fosse ammazzarsi a vicenda, appena se ne presenti l’occasione—evento cui abbiamo assistito in tempi ben più recenti rispetto al 1941—dietro l’amarezza e lo sconcerto si celasse la convinzione generica e forse ottimistica che sia più facile uccidere dei perfetti estranei rispetto a chi conosciamo meglio. Io non ne sono così sicuro. (…) L’unica volta che ebbi l’ardire di chiedere a mio padre perché non rivolgesse più la parola al fratello, un silenzio annichilente che durò gran parte della mia vita, mi rispose: «A volte è più facile avere a che fare con degli estranei».
In, interior, intimus. L’intimità può generare ben altre emozioni che non l’amore. Le persone con cui si è vissuto in grande intimità e promiscuità, che conoscono bene i tuoi sentimenti, soprattutto le tue debolezze: saranno proprio loro, nel momento cruciale, le prime a essere escluse, allontanate, scacciate, definitivamente cancellate. (pp. 188-189)