Il Papa è stato in America. I numerosi antiamericani che allignano anche nel mondo cattolico italiano hanno seguito quel viaggio obtorto collo. Si sa che anche le parole e gli atti del Papa possono essere, per così dire, tirati da una parte o dall’altra, o colorati secondo le lenti dell’osservatore. Ma ci sono parole inequivocabili, come quelle pronunciate nella Sinagoga di New York, o queste, che Benedetto XVI ha detto ieri, all’Udienza del 30 aprile.
Nell’incontro con il Signor Presidente nella sua residenza, ho avuto modo di rendere omaggio a quel grande Paese, che fin dagli albori è stato edificato sulla base di una felice coniugazione tra principi religiosi, etici e politici, e che tuttora costituisce un valido esempio di sana laicità, dove la dimensione religiosa, nella diversità delle sue espressioni, è non solo tollerata, ma valorizzata quale “anima” della Nazione e garanzia fondamentale dei diritti e dei doveri dell’uomo. In tale contesto la Chiesa può svolgere con libertà ed impegno la sua missione di evangelizzazione e promozione umana, e anche di “coscienza critica”, contribuendo alla costruzione di una società degna della persona umana e, al tempo stesso, stimolando un Paese come gli Stati Uniti, a cui tutti guardano quale ad uno dei principali attori della scena internazionale, verso la solidarietà globale, sempre più necessaria ed urgente, e verso l’esercizio paziente del dialogo nelle relazioni internazionali.
Qui mi sembrano importanti due cose: il riconoscimento dell’ordinamento statunitense come un modello per quanto riguarda laicità e libertà religiosa, da un lato, e la missione di “coscienza critica” della Chiesa dall’altro. Come teologo, Ratzinger ha attraversato i decenni creativi della teologia tedesca del Novecento, protestante e cattolica, e, nonostante tutto, questa eredità ogni tanto riemerge. Ma non è un’eredità ben legata al patrimonio dogmatico bimillenario della Chiesa cattolica, e, per quanto concerne la “coscienza critica” non proviene dal suo interno, ed è un qualcosa di eminentemente moderno. Qui si apre un problema apparentemente insolubile, o forse un paradosso: la “coscienza critica” non fa parte degli atteggiamenti interni ammessi dalla Chiesa stessa, mentre dovrebbe essere un suo atteggiamento esterno verso la realtà politico-sociale e le istituzioni altre. Ma una istituzione al cui interno la critica è bloccata può mai funzionare come “coscienza critica”? Ovvero, può davvero una istituzione essere “coscienza critica”? Poiché quello di una coscienza critica collettiva o addirittura istituzionalizzata mi sembra un concetto ambiguo e spurio, rimane alla radice la questione della coscienza critica individuale, delle sue prerogative e dei suoi limiti. Che all’interno della Chiesa sono strettissimi.
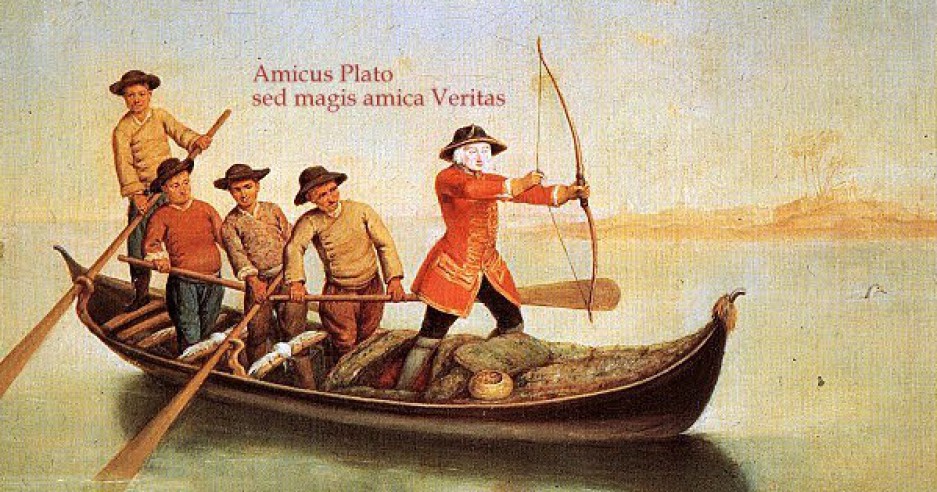

il dialogo universale tra le nazioni
non si fa con le bombe
americane che sicuramente si ispirano
alla laicita ma fanno spirare
ogni speranza
Il dialogo sicuramente non si fa con le bombe americane, ma nemmeno con quelle cinesi o russe, o con le cinture di tritolo dei massacratori suicidi. Che senso ha dire che delle bombe “si ispirano alla laicità”? La guerra è un tema su cui occorre ragionare a mente fredda, mentre l’accecamento delle passioni solitamente prevale e trascina tutti nella logica amico-nemico.
Io giudico l’attacco all’Iraq un grave errore strategico di Bush, e la dottrina militare utilizzata radicalmente erronea, mentre l’antiamericano vede rosso, solo rosso, e in questo rosso l’America e Israele come il cancro dell’umanità.
Quando avevo l’età per fare il militare, mi si pose il dubbio della scelta tra Servizio Militare stesso e Obiezione di Coscienza.
Pace, non violenza, altra guancia…..
ma anche, 12 mesi da buttare via, vicino o lontano da casa,…..
Ne venni fuori, a livello semantico.
Piuttosto che focallizzare l’attenzione su “militare” e “di coscienza”, trovai giusto analizzare prima “servizio” e “obiezione”.
Confrontare la realtà misera di certi aspetti della naja con gli alti splendienti ideali Gandhiani , non vale!
Se correttamente si mettevano a confronto realtà pratica con realtà pratica, nessuno ne esce brillantemente (quanti amici hanno fatto finta di fare il servizio civile presso una biblioteca 2 ore alla settimana….).
Il vero confronto doveva (deve) essere tra teoria e teoria.
Ora, se personalmente posso rinunciare a reagire allo schiaffo, e porgere anche l’altra guancia, mi riesce difficile spingermi al punto di imporre tale scelta al prossimo: se vedo un violento malmenare una vecchietta che faccio ? la tengo ferma per farle offrire l’altra guancia?
La civis, la polis, chiamiamola come ci pare, ha non il diritto, ma il dovere di proteggere i suoi membri.
Questo è il Servizio. che sia attuato in maniera “militare” è un “accidente” su cui discutere a livello applicativo (vedi norme di ingaggio), ma il concetto resta.
Non è un caso che nei momenti di alluvioni, terremoti e simili, a venire spostati in poche ore sul luogo del bisogno erano i soldati di leva, non i bibliotecari e gli accompagnatori di ciechi del servizio civile…..